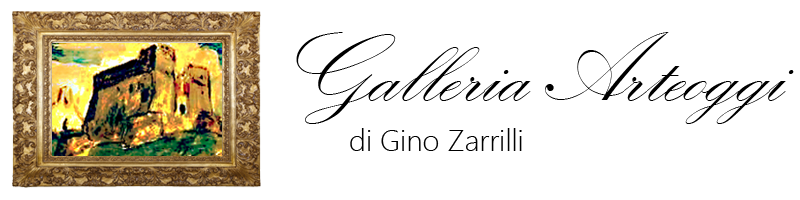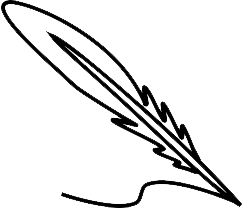Malacarne Claudio
- Data
- 19 Luglio, 2024
Numero: 53 E Autore: Malacarne Claudio Titolo: Giardino Tecnica: Olio su tela Misura: cm. 60z70 Firmato: In basso a destra Documenti: Certificato di autenticità della galleria, certificato di provenienza, cenni biografici del pittore e dichiarazione di autenticità del pittore su foto Cornice: Si

Biografia
 Claudio Malacarne nasce a Mantova nell’estate del 1956, quando il sole è già entrato nella costellazione del cancro. Fin dalle prime opere in lui il disegno si configura come un ambito d’azione e di riflessione privilegiato: vastissimo, autonomo e complementare al contempo alla pratica pittorica. È un laboratorio ininterrotto, un diario continuo in cui si assolve la necessità interiore, l’urgenza esistenziale di possedere la realtà attraverso l’immagine che la ricrea. Frequentando l’atelier del maestro Enrico Longfils si muove attraverso sperimentazioni di “mezzi diversi”, dalla matita, con cui soprattutto nello studio di animali insiste sulla plasticità dei soggetti, alla penna con inchiostro di china, prima a segni minuti e spezzati, poi a tratti più densi e continui, spesso sciolti in liquide acquarellature, preludio alla Natura morta con bottiglia, frutta e sveglia del 1970 in cui il disegno si dissolve nell’impulso pittorico. A partire dai dipinti a olio degli anni Ottanta s’intravede la lezione post-impressionista di Gauguin e di Van Gogh, di Bonnard e di Matisse, con una materia pittorica plein lumière, piuttosto che plein soleil: nelle ombre tanto sottilmente colorate da non essere neppure leggibili in quanto ombre, nel lampo fluorescente ed opalescente dei bulbi accesi nei suoi “giardini incantati” che spargono luce in tutto il paesaggio. C’è uno zampillio di colori che rimbalza sulle palme, sull’acqua del mare e sulle facciate delle case, quadruplicando il climax luminoso, nella precisa sensazione che questo – come nella narrativa di Proust o nella musica di Debussy – sia un istante sperduto nello spazio e nel tempo, irripetibile al pari di un candido pensiero, sostanziato di quiete, che solca la mente d’una fanciulla nel Ritratto della figlia Federica del 1989. Pur nel teso, coerente, ineccepibile linguaggio formale, le opere sul Concerto jazz del 2003-2008 grondano di umori esistenziali, come se il pittore lasciasse nelle serrate maglie di un’agguerrita sintassi simbolista i brani vivi, carnosi e sanguigni, della propria natura primordiale, inutilmente nascosta, perfino camuffata con ostinato pudore. Anche con le sue teste di animali nel Polittico del 2007, egli ha sempre lottato tra un proprio ideale mondo platonico, lucidamente dialettico e squisitamente mentale, e il gran flusso del suo sangue oscuro e tumultuoso, dei suoi sensi in agguato. Ed è appunto a causa di questo divario che si manifesta e determina la “fatica del pittore”, il tormento dei suoi quadri, espresso nel vigore del colore, nell’aggrovigliarsi delle immagini, nel sovrapporsi ed alternarsi dei dati naturalistici ed espressionistici sull’ordito logico di un’architettura figurativa neo-metafisica. Dopo aver scoperto il realismo spagnolo di Joaquín Sorolla, il suo occhio indagatore, il detective del colore dei Fauves, diventa nell’ultimo decennio, il puntuto, amaro artista dei “bagnanti” e dei “nuotatori”. Egli ha addirittura ingaggiato una battaglia contro il personaggio e sulla linea di un suo pirandelliano “uno, nessuno e centomila” ha puntato sulla presenza fisica della figura umana immersa nell’acqua di una piscina, divenendo dapprima il realista di una vita moderna perlustrata con una torcia al vetriolo, poi trasformandosi – lui ironico e scettico taglieggiatore di ritratti e di animali equiparati gli uni e gli altri da una comune, insopprimibile matericità – in una specie di perduto visionario suo malgrado. C’è in questi quadri tutta la sontuosa e avida eredità di Matisse, ma anche l’incanto, la sospensione, l’ansioso stupore di Rimbaud e di Valéry.
Claudio Malacarne nasce a Mantova nell’estate del 1956, quando il sole è già entrato nella costellazione del cancro. Fin dalle prime opere in lui il disegno si configura come un ambito d’azione e di riflessione privilegiato: vastissimo, autonomo e complementare al contempo alla pratica pittorica. È un laboratorio ininterrotto, un diario continuo in cui si assolve la necessità interiore, l’urgenza esistenziale di possedere la realtà attraverso l’immagine che la ricrea. Frequentando l’atelier del maestro Enrico Longfils si muove attraverso sperimentazioni di “mezzi diversi”, dalla matita, con cui soprattutto nello studio di animali insiste sulla plasticità dei soggetti, alla penna con inchiostro di china, prima a segni minuti e spezzati, poi a tratti più densi e continui, spesso sciolti in liquide acquarellature, preludio alla Natura morta con bottiglia, frutta e sveglia del 1970 in cui il disegno si dissolve nell’impulso pittorico. A partire dai dipinti a olio degli anni Ottanta s’intravede la lezione post-impressionista di Gauguin e di Van Gogh, di Bonnard e di Matisse, con una materia pittorica plein lumière, piuttosto che plein soleil: nelle ombre tanto sottilmente colorate da non essere neppure leggibili in quanto ombre, nel lampo fluorescente ed opalescente dei bulbi accesi nei suoi “giardini incantati” che spargono luce in tutto il paesaggio. C’è uno zampillio di colori che rimbalza sulle palme, sull’acqua del mare e sulle facciate delle case, quadruplicando il climax luminoso, nella precisa sensazione che questo – come nella narrativa di Proust o nella musica di Debussy – sia un istante sperduto nello spazio e nel tempo, irripetibile al pari di un candido pensiero, sostanziato di quiete, che solca la mente d’una fanciulla nel Ritratto della figlia Federica del 1989. Pur nel teso, coerente, ineccepibile linguaggio formale, le opere sul Concerto jazz del 2003-2008 grondano di umori esistenziali, come se il pittore lasciasse nelle serrate maglie di un’agguerrita sintassi simbolista i brani vivi, carnosi e sanguigni, della propria natura primordiale, inutilmente nascosta, perfino camuffata con ostinato pudore. Anche con le sue teste di animali nel Polittico del 2007, egli ha sempre lottato tra un proprio ideale mondo platonico, lucidamente dialettico e squisitamente mentale, e il gran flusso del suo sangue oscuro e tumultuoso, dei suoi sensi in agguato. Ed è appunto a causa di questo divario che si manifesta e determina la “fatica del pittore”, il tormento dei suoi quadri, espresso nel vigore del colore, nell’aggrovigliarsi delle immagini, nel sovrapporsi ed alternarsi dei dati naturalistici ed espressionistici sull’ordito logico di un’architettura figurativa neo-metafisica. Dopo aver scoperto il realismo spagnolo di Joaquín Sorolla, il suo occhio indagatore, il detective del colore dei Fauves, diventa nell’ultimo decennio, il puntuto, amaro artista dei “bagnanti” e dei “nuotatori”. Egli ha addirittura ingaggiato una battaglia contro il personaggio e sulla linea di un suo pirandelliano “uno, nessuno e centomila” ha puntato sulla presenza fisica della figura umana immersa nell’acqua di una piscina, divenendo dapprima il realista di una vita moderna perlustrata con una torcia al vetriolo, poi trasformandosi – lui ironico e scettico taglieggiatore di ritratti e di animali equiparati gli uni e gli altri da una comune, insopprimibile matericità – in una specie di perduto visionario suo malgrado. C’è in questi quadri tutta la sontuosa e avida eredità di Matisse, ma anche l’incanto, la sospensione, l’ansioso stupore di Rimbaud e di Valéry.
Floriano De Santi